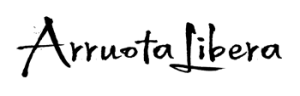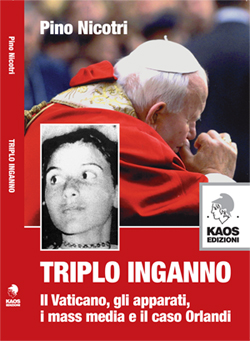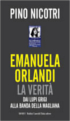Il Canada sarà un osso duro per Trump
di Mario Lettieri* e Paolo Raimondi**
La recente nomina di Mark Carney a primo ministro del Canada ha un significato ben maggiore di quello meramente nazionale. E va ben oltre la questione della guerra dei dazi iniziata da Donald Trump. Ha certamente a che fare con l’improvvida dichiarazione del presidente americano di voler annettere in un modo o nell’altro il Canada facendone il 51.imo stato della Federazione americana.
Trump a modo suo ha attaccato, ma non ha fatto i conti con l’”impero britannico”. La nomina di Carney, quindi, ci pare la risposta britannica. Trump è veramente consapevole delle implicazioni strategiche del suo gesto?
Il Canada, apparentemente indipendente e con un parlamento democraticamente eletto, è parte integrante del Commonwealth britannico, una formulazione più soft e moderna del vecchio impero. Innanzitutto, non si dimentichi mai che un ruolo centrale nella politica internazionale, per quanto possa sembrare strano, è della Corona britannica e che oggi il Capo di Stato del Canada è re Carlo III d’Inghilterra, che opera attraverso un suo governatore generale.
Londra e la City, il quartier generale della finanza mondiale, sono i massimi sponsor di Carney. La carriera del nuovo primo ministro canadese non è stata primariamente politica, non ha avuto molto a che fare con il gioco dei partiti. Carney è stato per quasi quindici anni l’uomo delle banche centrali. Prima, dal 2008 al 2013, come governatore della Bank of Canada, poi, dal 2013 al 2020. governatore della Bank of England. Il primo, in questo posto apicale, a non essere nato in Gran Bretagna. Questo ci dice molto di che cosa egli realmente rappresenta.
Fino alla sua nomina a capo di governo, Carney ha mantenuto tre passaporti: uno canadese, un secondo irlandese e un terzo britannico. La sua formazione è avvenuta all’università americana di Harvard e a quella inglese di Oxford. Prima delle banche centrali, per 13 anni aveva “imparato il mestiere” lavorando con la Goldman Sachs, la banca americana delle più grandi speculazioni finanziarie internazionali.
Assiduo partecipante ai maggiori simposi finanziari internazionali, Carney non è mai mancato agli incontri annuali di Jackson Hole, organizzati dalla Federal Reserve di Kansas City.
Al riguardo è opportuno ricordare alcuni suoi interventi, diventati noti per le posizioni di sfida al ruolo internazionale del dollaro.
Nel simposio del 2019, per esempio, Carney dichiarò che “un sistema unipolare non è adatto per un mondo multipolare” e che “l’uso diffuso del dollaro statunitense nella fatturazione commerciale, al posto della valuta del produttore o dell’importatore”, ha avuto un effetto “destabilizzante” sull’economia globale. Metà delle transazioni commerciali mondiali è effettuata ancora in dollari, ma la quota delle importazioni Usa è solo un quinto del totale dell’import mondiale, diceva.
In quell’occasione, dopo aver ricordato che “la City è il principale centro finanziario internazionale”, egli propose di sostituire il dollaro, come moneta di riferimento negli scambi commerciali e nelle riserve internazionali, con la Synthetic Hegemonic Currency (Shc), una nuova valuta digitale che avrebbe dovuto essere emessa dalle banche centrali attraverso una loro rete di monete digitali. Prendeva come esempio la moneta digitate Libra, allora proposta da facebook.com, che sarebbe potuto diventare il nuovo strumento di pagamento per le transazioni commerciali.
Dalla Bank of England Carney si era opposto alla Brexit poiché aveva capito che l’isolamento britannico avrebbe avuto conseguenze economiche e politiche negative per Londra. Aveva ragione, come si può dedurre dall’attivismo di Starmer verso l’Europa.
L’integrazione economica tra il Canada e gli Stati Uniti è già molto forte, a prescindere dalle dichiarazioni e dalle intenzioni di Trump. Più del 75% delle esportazioni canadesi va negli Usa. Di conseguenza il gioco dei dazi è più propaganda che altro. Pertanto la questione è squisitamente geopolitica e riguarda il controllo americano sulle materie prime e sul vasto territorio del Canada.
Il “patriota” Trump , dovrebbe sapere bene che gli Usa conquistarono la loro indipendenza dall’impero britannico con una rivoluzione voluta dal popolo, né comprata né imposta dall’alto. Non sembra che i canadesi vogliano essere annessi come cittadini di secondo grado nel nuovo ordine mondiale trumpiano. Inoltre, è opportuno anche ricordare che nella Guerra di Secessione Londra prese apertamente e concretamente la parte degli Stati della Confederazione del Sud contro Lincoln.
Non è in corso una partita a scacchi per cui si possono rimettere i pezzi al loro posto e ricominciare daccapo. La realtà non può essere violentata a piacimento. Trump potrà portare avanti solo quelle politiche che è veramente in grado di realizzare. Il resto è pura propaganda.
*già sottosegretario all’Economia **economista