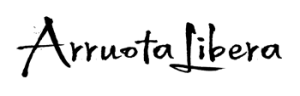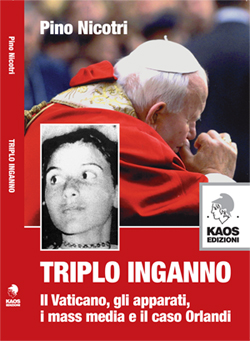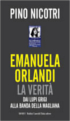La democrazia formale (II)
L’ASSENZA DI RESPONSABILITA’ PERSONALE
In assenza di autogestione, la democrazia resta formale anche quando, dopo una crisi di governo, si verifica l’alternanza nella guida di un Paese. Una democrazia delegata che non prevede quella diretta rappresenta solo una gestione elitaria del potere, soggetta continuamente al pendolo fra anarchia e dittatura. Infatti, quando l’aristocrazia politica s’accorge che i suoi metodi non garantiscono ai gruppi oligarchici la necessaria stabilità economica, ecco che scatta l’esigenza di cercare “l’uomo della Provvidenza”.
Quando la democrazia parlamentare è in crisi, perché i soggetti politici si sono dimostrati incapaci di governare e non godono più alcuna fiducia da parte degli elettori, è facile che qualche gruppo parlamentare inizi a rivendicare un rapporto diretto con le masse (magari in questo viene sollecitato da altri gruppi o movimenti extraparlamentari).
Improvvisamente la democrazia tende ad assumere un atteggiamento ambivalente: facendo ricorso, specie attraverso i media, all’istintività delle masse (populismo), essa mira a cercare una legittimazione dell’autoritarismo al di fuori dell’ambito meramente parlamentare. L’obiettivo è soltanto quello di rafforzare l’esecutivo, le funzioni monocratiche del governo o di affermare addirittura un personalismo presidenziale.
Fra la democrazia delegata e l’anarchia è dunque difficile dire cosa sia meglio, poiché la prima si trasforma facilmente in un arbitrio legalizzato (“di Stato”), patrimonio di pochi: il che può comportare conseguenze più nefaste dell’arbitrio dei singoli cittadini.
Non è forse singolare che nei Paesi a democrazia delegata ci si appelli al principio della “responsabilità personale” solo quando si tratta di punire il cittadino per aver compiuto un’azione illegale? “Positivamente” la responsabilità personale, in una democrazia delegata, non appartiene a nessuno: a chi comanda infatti spetta il privilegio dell’arbitrio, a chi ubbidisce il dovere di sottostarvi.
Per i governi delle democrazie delegate un esempio di cittadino modello è quello che obbedisce alle leggi dello Stato e paga le tasse, cioè obbedisce a leggi e tasse che “altri” gli hanno imposto, senza chiedergli alcun parere.
Il massimo della democrazia diretta, in questi Paesi, è rappresentato dall’esercizio del referendum popolare, cioè dalla possibilità (piuttosto lenta e macchinosa) di abolire una legge già in vigore.
UN NUOVO RAPPORTO TRA ELETTO ED ELETTORE
La vera democrazia non può essere delegata se l’eletto non è un’espressione diretta dell’elettore, cioè un’emanazione circostanziata nel tempo e nello spazio, che può essere facilmente tenuta sotto controllo.
L’eletto deve rappresentare costantemente la volontà di un elettore particolare (che può essere un gruppo, una comunità, sempre di dimensioni ristrette, poiché l’eletto deve costantemente tenersi in rapporto, in contatto con la base che l’ha votato).
Per essere veramente efficace, l’esercizio della responsabilità personale deve essere quotidiano, in modo tale che i risultati di tale impegno si possano vedere con una certa periodicità.
Se l’esercizio di tale responsabilità non comporta, col tempo, una progressiva trasformazione della società (nel suo complesso e non soltanto in singoli settori), facilmente la democrazia involve verso una gestione arbitraria del potere. Quanto più gli antagonismi, gli abusi… diventano un male endemico, tanto più si vanno a cercare soluzioni estreme, categoriche, destinate soltanto a peggiorare le cose.
Naturalmente l’eletto, in una democrazia diretta, è a sua volta un membro della comunità che lo ha votato: ciò significa ch’egli non può limitarsi a rappresentare passivamente la volontà di altri, ma deve interagire con tale volontà, manifestando le proprie opinioni.
Le masse popolari, di per sé, non sono migliori dei singoli eletti (a volte non sono migliori neppure dei singoli autocrati). Cosa sono stati, in fondo, il nazi-fascismo e lo stalinismo se non la miscela di due volontà perverse: una individuale (consapevole) e l’altra collettiva (strumentalizzata)?
Per questa ragione non ha senso sostenere che laddove le masse pretendono maggiore protagonismo, lì c’è sicuramente più democrazia. La democrazia non è un concetto che si può ipostatizzare, non è mai una definitiva acquisizione: la sua presenza va dimostrata ogni volta, in quanto è sempre un obiettivo da raggiungere. Se non fosse così, noi p.es. non riusciremmo a spiegarci il passaggio dal comunismo primitivo allo schiavismo.
Al massimo si potrebbe dire questo: la democrazia è molto di più un obiettivo nelle formazioni sociali antagonistiche che non in quelle collettivistiche, nel senso che mentre nelle prime il raggiungimento dell’obiettivo comporta un preliminare rovesciamento del sistema, nelle seconde invece comporta di quest’ultimo una progressiva evoluzione.
In un tipo di sistema la democrazia affermata come valore serve per ricordare agli uomini che non sono delle bestie selvagge; in un altro tipo serve a ricordare che, se tradiscono certi ideale, possono sempre diventarlo.
Di sicuro noi sappiamo solo una cosa: che è più facile realizzare la democrazia là dove la gente è abituata a decidere, cioè ad assumersi direttamente delle responsabilità. Certo, anche questa gente può compiere delle scelte sbagliate o addirittura lasciarsi corrompere, ma avrà meno motivi di addebitarne la causa a enti impersonali o a persone estranee.
* * *
Quando c’è l’esigenza di farsi rappresentare, deve esserci inoltre la possibilità di potersi rappresentare da soli. Vi possono infatti essere dei casi così gravi (minacce alla libertà, violazioni di diritti, disastri ambientali…) per i quali l’intervento diretto di un gruppo o dell’intera comunità è più efficace di qualunque altra soluzione.
Per queste ragioni la democrazia diretta, che è poi l’unica vera democrazia, può funzionare solo quando la comunità sociale non è troppo grande, cioè quando esiste, in concreto, la possibilità di controllare l’operato dei cittadini e quindi anche dei loro delegati, che devono poter essere rimossi in qualunque momento se vengono meno al mandato ricevuto (ciò ovviamente significa che all’eletto va data la possibilità di difendersi).
In tal senso è assurdo che una persona possa pretendere di fare il politico di professione. La politica è lo strumento per rivendicare dei diritti, per gestire degli spazi, per prendere delle decisioni, per risolvere dei conflitti sociali: non può essere una dimensione di vita.
La politica è un contenitore che può essere riempito solo di tutto ciò che non è politico. Quando la politica si rende autonoma dalla vita sociale e dalla cultura, diventa eo ipso arbitraria, sempre e comunque, a prescindere dalle sue azioni particolari.
QUALI SPERANZE PER IL FUTURO?
La storia spesso manifesta questo singolare aspetto: proprio mentre le forze regressive s’incaponiscono a difendere i loro privilegi e la cultura del passato, che ha già perso di credibilità, tende a formarsi l’alternativa per il futuro. Questa, tuttavia, per risultare vincente, ha bisogno di porsi in maniera creativa e costruttiva: non può limitarsi ad attendere che il consenso le venga consegnato su un piatto d’argento. Anche perché il crollo rovinoso della reazione potrebbe travolgerla.
In altre parole, proprio mentre è più forte il potere politico e militare delle forze conservatrici, molto più debole è il loro potere morale, la loro legittimazione sociale – ed è questo, in definitiva, che deciderà la loro sorte.
Questo momento di transizione sarà tanto più veloce, tanto meno cruento quanto più risoluta sarà la resistenza delle forze regressive. Naturalmente la velocità della transizione non è di per sé un indice sicuro della sua democraticità: la velocità distruttiva di certe rivoluzioni (si pensi p.es. a quella francese) s’è trasformata ben presto in altrettanta velocità autodistruttiva.
In effetti, non basta la fiducia dei cittadini per essere sicuri che le nuove istituzioni saranno caratterizzate eticamente. Occorre anche e soprattutto che si realizzi la democrazia sociale, per la quale le istituzioni hanno compiti davvero limitati. Un’istituzione ha senso solo quando non può staccarsi dalla società, e questo, quando una società per secoli ha convissuto con la realtà delle istituzioni, è più facile a dirsi che a farsi.
Il cittadino democratico dovrà abituarsi all’idea che in una società autogestita ogni abuso si ripercuote immediatamente su tutti i cittadini, nessuno escluso: o si vive insieme nel bene comune o nessuno si salva. Là dove esiste la democrazia sociale, la corruzione non può dilagare come un cancro incurabile.