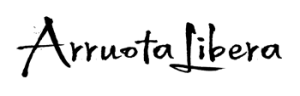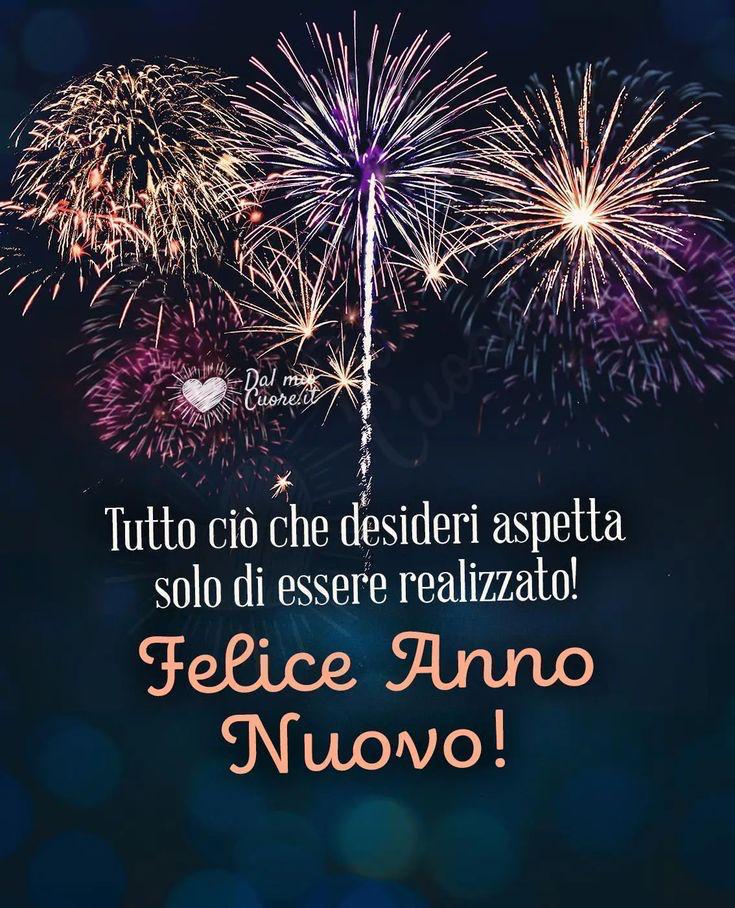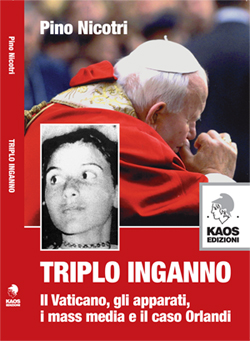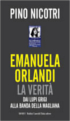L’oro e la nuova moneta internazionale
Mario Lettieri* e Paolo Raimondi**
I media occidentali sono talmente impegnati ad analizzare gli andamenti dello scontro militare in Ucraina da sottovalutare quanto sta avvenendo in altri settori strategici, ad esempio quello monetario.
Qualche settimana fa si era evidenziato come, in alternativa al dollaro, la Russia, la Cina e altri Paesi stessero discutendo di una nuova moneta internazionale per regolare i propri scambi commerciali e altre operazioni finanziarie. In particolare, si segnalava la proposta del noto economista russo Sergey Glazyev che prefigurerebbe una moneta basata su un paniere di valute, tra cui il rublo e lo yuan, ancorata al valore di alcune materie prime strategiche, incluso l’oro.
Durante il 2022, l’inasprimento delle sanzioni occidentali nei confronti della Russia ha indotto Mosca a preferire altri partner economici come la Cina, l’India, l’Iran, la Turchia, l’Egitto, gli Emirati arabi uniti, ecc. Con ciascuno di loro, la Federazione russa ha un surplus commerciale. Secondo le stime della Banca centrale russa, nel periodo gennaio-settembre 2022 esso sarebbe di 198,4 miliardi di dollari, cioè 123,1 miliardi in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
L’ammontare indubbiamente non compensa quanto si è perso nei commerci con l’Europa e con l’intero Occidente, ma rappresenta uno sviluppo alternativo. Detto ciò il cambiamento ha spinto molti economisti russi e dei Paesi non ostili alla Russia a promuovere delle nuove proposte in materia monetaria.
Lo rivela un recente articolo pubblicato sulla rivista russa Vedomosti da Sergey Glazyev, insieme a Dmitri Mityaev, segretario esecutivo del Consiglio scientifico e tecnico della Commissione economica eurasiatica. Vi si afferma che a settembre la Russia è diventata il terzo Paese al mondo nell’utilizzo dello yuan per i pagamenti internazionali. Lo yuan oggi rappresenta il 26% delle transazioni in valuta estera della Federazione Russa. Glazyev afferma che con tutti i partner commerciali c’è stato un grande utilizzo delle monete locali e, a seguito dei surplus, Mosca ha accumulato grandi quantità di tali monete nelle banche dei partner.
Poiché si stima che l’accumulo di fondi in queste valute aumenterà in futuro e che esse potrebbero essere soggette a rischi di cambio e di possibili sanzioni, gli economisti russi propongono di cambiare questa massa di monete locali in oro. In parte sarebbe tenuto nelle riserve dei Paesi coinvolti e utilizzato per regolamenti transnazionali, scambi di valute e operazioni di compensazione, e in parte rimpatriato in Russia.
L‘analisi afferma, inoltre, che anche in Occidente si pensa che, a causa dei rischi finanziari, nel 2023 l’oro potrebbe diventare un importante strumento d’investimento, accrescendone il suo valore. Il che andrebbe a beneficio dei Paesi detentori del metallo prezioso. Le grandi riserve auree consentirebbero loro di perseguire una politica finanziaria sovrana e di ridurre la dipendenza dai creditori esterni.
Glazyev afferma che la Russia ha già grandi riserve auree e valutarie. E’ la quinta al mondo, dopo Cina, Giappone, Svizzera e India, e davanti agli Stati Uniti. A livello mondiale il volume dell’oro accumulato sarebbe pari a 7.000 miliardi di dollari, di cui le banche centrali non avrebbero più di un quinto. Sarebbe in atto, secondo gli economisti russi, una vera e proprio corsa all’oro, tanto che nel terzo trimestre del 2022 le banche centrali avrebbero acquistato una quantità record di 400 tonnellate d’oro.
La People’s Bank of China ha annunciato per la prima volta in molti anni che sta aumentando le sue riserve auree. La Cina è al primo posto nella produzione di oro e ne vieta l’esportazione. L’India è considerata il campione mondiale nell’accumulo di oro: più di 50.000 tonnellate in gran parte in mani private e molto meno nella Reserve Bank of India. Negli ultimi 20 anni, il volume dell’estrazione dell’oro in Russia è raddoppiato, mentre negli Stati Uniti si è quasi dimezzato.
A Mosca, però, tale politica non avrebbe un completo sostegno, tanto che Glazyev attacca la Banca centrale perché per essa l’acquisto di oro provocherebbe un’eccessiva monetizzazione dell’economia.
Si potrebbe, quindi, dire che non è tutto oro ciò che luccica, ma sarebbe miope non analizzare quanto scritto in Vedomosti e quanto accade in molti Paesi. Nel mondo delle monete, il ruolo dell’oro sta ritornando al centro delle discussioni. E’ un fatto!
*già sottosegretario all’Economia **economista