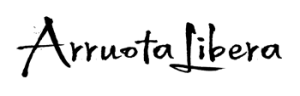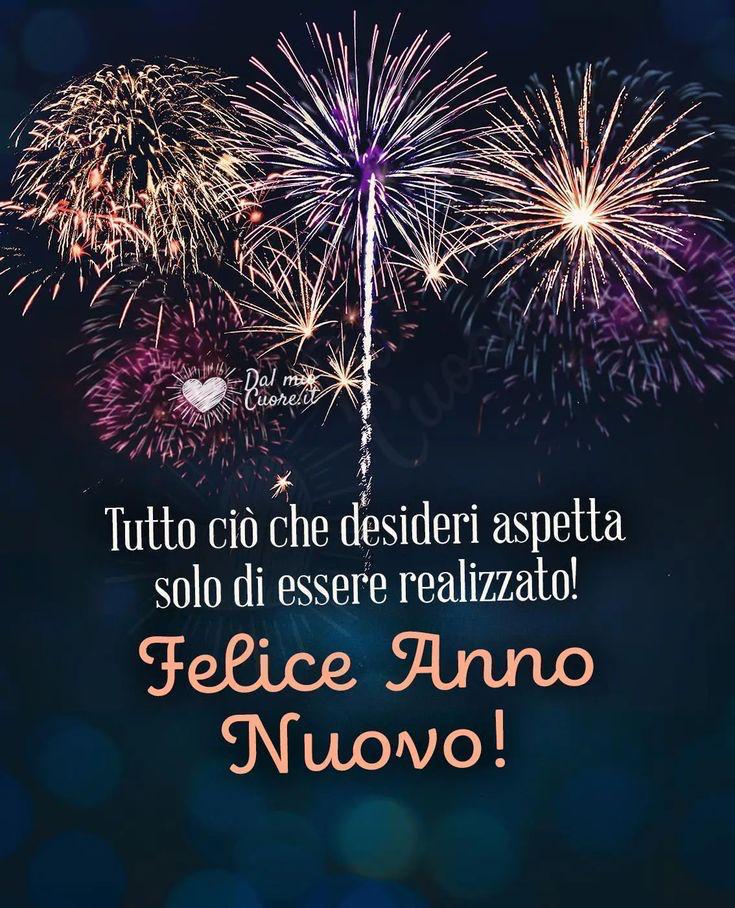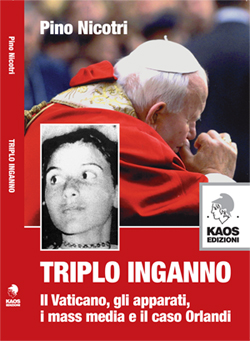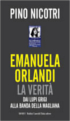Crisi bancarie Usa: le responsabilità dei controllori
di Mario Lettieri* e Paolo Raimondi**
Serve chiarezza. Dietro le recenti bancarotte negli Usa ci sono altri motivi di preoccupazione. In primo luogo il fallimento delle autorità di sorveglianza, a cominciare dalla Federal Reserve.
Il loro mancato intervento, a nostro avviso, è dovuto al fatto che esse erano pienamente consapevoli che le loro politiche monetarie altalenanti, interessi zero prima e aumento dei tassi poi, avrebbero messo sottosopra il sistema bancario. Hanno ritenuto, erroneamente, che astenersi fosse la seconda tra le peggiori possibilità. La prima sarebbe stata continuare con le politiche di poderose iniezioni di liquidità fino a far esplodere la bolla.
Il governo e le autorità bancarie, quindi, non sono stati colti di sorpresa. Erano pronti a nuovi interventi di salvataggio dell’intero sistema. Meglio intervenire dopo il fallimento di una banca regionale che di una too big to fail. C’è stato, infatti, un barrage di interventi. Si è creata una Bank Bailout Facility attraverso la quale il governo concede dei prestiti alle banche. La Fed ha annunciato un “discount window”, uno sportello, dove attingere a prestiti di emergenza a basso costo. Sotto la guida della Fed e del Tesoro, sei grandi banche, JP Morgan, Wells, Citi, Bank of America, Goldman Sachs e Morgan Stanley, si sono accordate per mettere a disposizione 30 miliardi di dollari per la First Republic Bank. Non sono bastati, però, a fermare il crollo. Anche la Federal Deposit Insurance Corporation, l’agenzia di protezione finanziaria, è entrata in campo per garantire i depositi fino a 250.000 dollari. Si tenga presente, però, che il suo fondo coprirebbe soltanto il 2% dei 9.600 miliardi di dollari di depositi assicurati.
E’in atto anche una narrazione che cerca di distogliere l’attenzione dalle banche too big. Si parla insistentemente dei rischi di insolvenza delle banche regionali e delle cosiddette saving and loans banks, quelle che raccolgono i risparmi e poi concedono prestiti alle imprese locali e alle famiglie. Indubbiamente non si possono negare le loro difficoltà attuali, create proprio dagli andamenti dei tassi d’interesse. Si ricorderà che una crisi simile, ma in una situazione di differente gravità sistemica, era avvenuta già negli anni ottanta, sempre per effetto della crescita vertiginosa dei tassi d’interesse da parte della Fed.
E’ comunque da ingenui ritenere che le banche regionali siano delle entità totalmente indipendenti rispetto alle 20 maggiori banche Usa, cosiddette, sistemiche. Secondo JP Morgan nell’ultimo anno le banche più piccole avrebbero perso 1.100 miliardi di dollari in depositi che sono stati trasferiti in quelle più grandi.
C’è anche un’altra narrazione che vorrebbe le banche europee, e non quelle americane, essere nell’occhio del ciclone. Certamente, dopo la crisi del Credit Suisse e le gravi fibrillazioni della Deutsche Bank (DB), non si può negare che il sistema bancario europeo sia in crescente difficoltà.
Noi non ci siamo mai stancati di denunciare i comportamenti rischiosi di DB, superstar dei derivati otc. Ma non si può nemmeno dimenticare che il sistema bancario europeo sia entrato in acque agitate proprio per aver copiato i metodi speculativi di quello americano e della City inglese.
E’ doveroso anche notare il macroscopico errore delle agenzie di rating, le note imprese americane private. Fino al giorno prima del fallimento della Silicon Valley Bank, Moody’s le garantiva il voto di A3 e Standard & Poor’s (S&P) le dava un rating un po’ inferiore di Bbb. Certamente erano lontani dalle triple A elargite a piene mani prima della bancarotta della Lehman Brothers. I titoli della Svb, però, erano considerati “investment grade”, cioè degni di investimento e perciò non speculativi.
Si noti che, anche rispetto al fallimento della First Republic Bank, le agenzie di rating S&P e Fitch hanno inserito la banca tra le imprese “junk”, spazzatura, solo dopo gli interventi di salvataggio.
Nelle prospettive bancarie globali per il 2023, la S&P afferma che il settore bancario statunitense è in buona salute e che il rischio è in calo. Per la Moody’s le prospettive sarebbero stabili, sebbene avvertisse venti contrari in un’economia in rallentamento.
Si tratta di gravi sottovalutazioni, a discapito dei risparmiatori e degli onesti investitori. Si persegue un comportamento, a dir poco incompetente e inadeguato, già emerso prepotentemente nel 2001 alla vigilia del fallimento della Enron, il gigante americano dell’energia, e poi nella Grande Crisi del 2008.
Dal 2001 il Congresso americano ha portato avanti varie iniziative di riforma che, però, non hanno indotto le agenzie di rating a un comportamento più corretto.
Si dovrebbe tenerlo presente quando esse pontificheranno sulla situazione economica e finanziaria dell’Italia. In passato, purtroppo, si è sempre tenuto un atteggiamento troppo supino.
*già sottosegretario all’Economia **economista