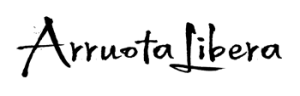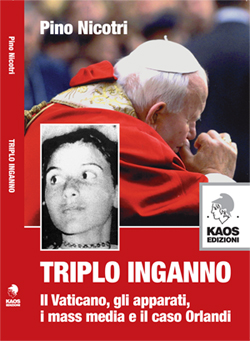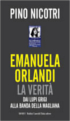L’agenzia di rating africana è in costruzione
di Mario Lettieri* e Paolo Raimondi**
Mentre i paesi europei sembrano essersi assoggettati in modo definitivo ai dettami delle tre sorelle americane del rating, l’Africa, invece, lavora per creare un’agenzia di rating africana. Lo ha ribadito l’economista nigeriano Akinwomi Adesina, presidente della Banca africana per lo sviluppo (Afdb), nella sua riunione annuale tenutasi recentemente a Nairobi, in Kenya.
L’intenzione del Consiglio dei governatori della banca è di avere “una valutazione equa e adeguata delle operazioni sovrane e non sovrane del continente”. L’obiettivo “non è quello di competere con le agenzie di rating internazionali, ma di stabilire una nuova cultura della valutazione che tenga conto delle diverse specificità delle economie africane”.
Adesina stima che la creazione di un’agenzia africana farà risparmiare ogni anno più di 75 miliardi di dollari, spesi per il servizio del debito a causa di un rating “ingiusto”. Si tratta di una somma notevole che potrebbe essere destinata a progetti di sviluppo.
Le tre agenzie di rating americane, Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch, controllano il 95% del business del rating globale e utilizzano dei parametri classici, tra cui la crescita del pil, il reddito procapite, il debito pubblico, i livelli storici dell’inflazione e dei fallimenti e la presunta stabilità delle istituzioni.
L’Afdb raccomanda, tra l’altro, di rivedere il metodo di calcolo del pil delle economie africane includendo la ricchezza del sottosuolo, le materie prime, il potenziale della forza lavoro giovanile. E, poiché l’Occidente mette tra le sue priorità l’ambiente, i consumi e la riduzione delle emissioni di CO2, l’Africa vuole giustamente che sia parametrato anche il contributo ecologico del continente (foreste, stoccaggio del carbonio, ecc.).
Qualche settimana prima era stata l’Unione Africana a sostenere con forza la necessità di sottrarsi ai dettami delle “tre sorelle del rating” e lavorare per un’agenzia tutta africana. L’idea di un’Acra, African credit rating agency, era stata formulata già nel 2017 e sostenuta anche da vari organismi delle Nazioni Unite.
Sebbene non abbiano una presenza attiva nel continente africano e spesso utilizzino i dati della Banca Mondiale o delle istituzioni centrali africane, le agenzie americane, sfruttando le divisioni interne all’Africa e le inadeguatezze burocratiche, hanno potuto, indisturbate, “pontificare” sugli andamenti economici dei paesi africani.
Oggi le cose sono cambiate. L’Africa non è più in balia degli eventi. E’ parte attiva del cosiddetto Sud Globale ed è capace anche di mettere in campo una dirigenza preparata e competente. Ecco perché i governatori dell’Afdb hanno anche sollecitato la riforma dell’architettura finanziaria globale che dovrebbe essere accompagnata dall’intensificazione degli sforzi da parte dei paesi africani per migliorare l’ambiente macroeconomico.
L’Afdb è consapevole che le tensioni geopolitiche internazionali, l’inflazione sui prezzi del cibo e le politiche monetarie esterne rendono molto difficile realizzare lo sviluppo se concepito con i vecchi metodi di sudditanza e di dipendenza dalla “benevolenza” degli altri. E’, però, anche consapevole delle enormi ricchezze del continente: le materie prime di ogni tipo, le terre rare, l’acqua, le foreste e una crescente popolazione giovanissima. Si consideri che l’età media è di circa 19 anni.
Oggi, però, mentre gli “asset under management”, i patrimoni in gestione, globalmente sono pari a circa 120.000 miliardi di dollari, la quota africana è soltanto di 2.500 miliardi.
Il programma è “accelerare la trasformazione dell’Africa”. Per realizzare entro il 2030 gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Onu il gap finanziario annuale è aumentato da 2.500 a 4.000 miliardi di dollari. L’Africa avrebbe bisogno di 1.330 miliardi l’anno per realizzare gli obiettivi. Una cifra non da poco.
Ecco perché la Banca africana ha anche messo al centro delle future attività finanziare l’attivazione del settore privato, interno e internazionale. Attraverso varie forme di garanzia e di mitigazione dei rischi, si vuole favorire una partecipazione privata a investimenti di sviluppo reale, nelle infrastrutture, nell’agricoltura, nei settori sociali e in particolare nell’industria. Infatti, il settore manifatturiero contribuisce soltanto per il 10% al pil dell’Africa. Sulla scia delle esperienze del Brics, stanno crescendo anche le emissioni di obbligazioni per lo sviluppo nelle monete africane locali. In tutto questo l’African Development Forum, la piattaforma per lo sviluppo creata dall’Afdb nel 2018, ha un ruolo importante. In pochi anni ha già mobilitato investimenti per 180 miliardi di dollari.
*già sottosegretario all’Economia **economista