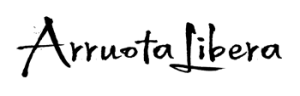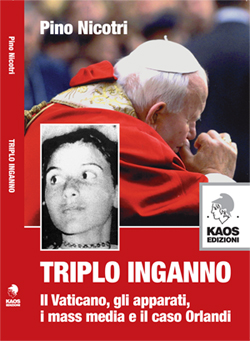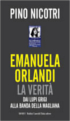Il Mediterraneo – una volta il Mare Nostrum – tornerà ad essere ciò che il suo nome significa, e cioè “In mezzo alle terre”, dove per terre si intende l’Europa, l’Africa e l’Asia? E’ possibile, se non probabile o certo. E a riempire concretamente il significato del suo nome sarà il poker d’assi porti italiani di Genova e Trieste e quelli spagnoli di Bilbao e Valencia più quello portoghese meridionale di Sines: questo infatti anche se affacciato sull’Atlantico farà da snodo verso l’Africa. Questi cinque porti saranno i terminali occidentali del gigantesco progetto cinese Belt and Road Initiative, in sigla BRI, noto anche come Nuova Via della Seta, al quale hanno già aderito 60 Paesi più oltre 40 organizzazioni internazionali e che intende stimolare anche con rotte navali non solo l’integrazione dei commerci e delle economie dei tre continenti citati, ma diventare per loro “un percorso che porta all’amicizia, allo sviluppo condiviso, alla pace, all’armonia e ad un futuro migliore”. Lo ha dichiarato a Shangai lo scorso novembre il presidente della Cina Xi Jinping all’International Economic and Trade Forum, al quale il 5 novembre ha partecipato, con il suo secondo viaggio in Cina, il nostro vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio ( https://video.repubblica.it/politica/shanghai-la-gaffe-di-luigi-di-maio-il-presidente-xi-jinping-diventa–ping/318842/319471 ).
Poche settimane dopo avere pronunciato quelle parole il presidente Xi è stato in visita in Spagna dal 27 al 29 dello scorso novembre per proporre l’adesione alla BRI anche alla Spagna, Paese nel quale l’anno scorso la compagnia navale cinese Cosco Shipping Holdings si è aggiudicato il 51%, cioè la maggioranza assoluta, del gruppo spagnolo Notaum Port, gestore dei servizi portuali per le navi container a Bilbao e Valencia. E se la Spagna si è riservata di decidere, il Portogallo invece lo scorso 5 dicembre ha aderito e concesso per la BRI lo sbocco nel porto di Sines, sulla costa meridionale del Portogallo e poco distante dallo Stretto di Gibilterra. Oltre a funzionare come punto di raccolta delle merci della BRI da irradiare verso l’Africa, Sines sarà di fatto per la Nuova Via della Seta anche la porta di ingresso al Mediterraneo, dove la BRI potrà contare sui quattro porti sopra citati, due francesi e due italiani. Di questo poker di porti del Mediterraneo alla Cina interessa in particolare quello di Trieste perché è l’unico porto europeo che gode di extraterritorialità doganale ed è collegato via treno all’Europa centrale e orientale.
Diciamo subito per completezza d’informazione che ci sono anche voci molto contrarie alla Nuova Via della Seta, vista come un tentativo di allontanare l’Italia dalla Nato (ma a cosa serve una volta scomparsa l’URSS e annesso “pericolo comunista”?) e dall’Europa. Tra i contrari spicca da tempo Alessia Amighini, Co-direttrice dell’Osservatorio Asia presso l’Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI https://www.ispionline.it ). Amighini rileva che “Gli altri grandi esportatori europei , di cui si lamenta la maggior forza economica e commerciale in Cina, non hanno firmato MoU (NDR: sigla inglese per Lettera di Intenti), ma guidato e sostenuto cordate e missioni di imprese per firmare contratti e accordi concreti”. E conclude: “Il MoU tra Italia e Cina è destinato indubbiamente a sigillare il ruolo strategico dell’Italia come ponte strategico della Cina in Europa, e non invece come ponte tra Ue e Cina. Sperare che almeno intensifichi il commercio e gli investimenti non basta a compensare le remore di un documento le cui conseguenze politiche non riusciamo ora nemmeno a immaginare”.
Il pioniere dei rapporti economici con la Cina è stato indubbiamente il socialista Gianni De Michelis quando era il nostro ministro degli Esteri, e non solo perché essendo veneziano aveva letto Il Milione di Marco Polo. De Michelis fondò a Padova una associazione per incrementare la reciproca conoscenza e gli scambi tra Italia e Cina a partire dal Veneto. Anche Romano Prodi quando era il nostro premier ha intrapreso iniziative a favore dei contatti e degli scambi Italia-Cina. Silvio Berlusconi invece quando era premier ha rinviato e infine annullato per ben tre volte il suo viaggio di Stato in Cina, preferendo invece altri impegni. Dopo queste premesse nostrane l’Italia sarà il primo Paese europeo ad aderire anche con sue infrastrutture al grande progetto cinese della Nuova Via della Seta? E’ molto probabile, se non certo. Si intitolava “La Cina è vicina” il film, alquanto noioso, di Marco Bellocchio del ’67, in piena epoca di comunismo avanzante in piazza e alle votazioni e anticamera del famoso ’68. Ma in realtà la Cina era lontana. Lontanissima. Oggi, morto il comunismo, la realtà è che la Cina non solo è vicinissima, ma è ormai tra noi. La Lunga Marcia ( https://it.wikipedia.org/wiki/Lunga_marcia ) intrapresa da Mao Tzedong (all’epoca si scriveva Mao Tze Tung ) è infatti proseguita, ha mutato volto e prosegue tuttora alla grande, anche se con sviluppi decisamente imprevisti e tra pochi giorni farà tappa in Italia. Ma andiamo per ordine.
Fino al crollo dell’Unione Sovietica e del comunismo l’Italia era la portaerei USA e Nato posta tra il mondo capitalista a ovest e il mondo comunista a est. Il Portogallo, a partire dalle isole Azzorre, e l’intera penisola iberica erano considerate dal Pentagono e dalla Nato la parte iniziale di un imbuto che andava man mano allargandosi all’intera Europa con la disseminazione di basi militari. In Spagna è successo perfino, il 17 gennaio ’66, che quattro bombe atomiche a stelle e strisce precipitassero da un bombardiere, una in mare, una su un terreno privato, una vicino alla foce di un fiume e una in montagna, per fortuna tutte senza scoppiare nonostante l’esplosione dell’innesco ( https://it.wikipedia.org/wiki/Incidente_di_Palomares ). Oggi vediamo la Cina in procinto di firmare accordi che fanno dell’Italia il porto navale cerniera tra Occidente e Oriente dopo avere stipulato accordi ( https://www.blitzquotidiano.it/opinioni/nicotri-opinioni/portogallo-cinesi-trump-via-seta-2966291/ ) che fanno della penisola iberica, e in particolare del Portogallo comprese le Azzorre, la base e il trampolino di lancio per linee di navigazione commerciale che si irradiano ad imbuto non solo verso l’ Europa, ma anche verso l’Africa e lo stesso continente americano. Il tutto mentre gli investimenti cinesi in questi tre continenti vanno al galoppo, al punto da avere provocato all’Italia il 7 marzo un duro ammonimento stop USA ( https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/Stop-degli-Stati-Uniti-a-Di-Maio-ingresso-Italia-Via-della-Seta/ ) e ammonimenti dell’Europa ( https://www.italiaoggi.it/news/i-maggiori-acquisti-della-cina-in-europa-sono-stati-fatti-in-germania-e-in-gran-bretagna-perche-l-allarme-2342518 ) perché vengano messi un freno e un argine alla campagna acquisti lanciata da anni da Pechino e supportata massicciamente dal grandioso progetto della Nuova Via della Seta/Belt and Road Initiative. Un progetto destinato a cambiare oltre alla realtà economica europea la realtà geopolitica del pianeta, specie se viene realizzata completamente anche l’iniziativa russa Razvitie ( https://www.blitzquotidiano.it/opinioni/nicotri-opinioni/russia-corridoio-razvitie-la-transiberiana-dello-sviluppo-1904773/ ), per certi versi geograficamente parallela alla cinese BRI.
L’occasione per la nuova tirata d’orecchie è la visita di Stato in Italia del presidente cinese Xi Jinping, prevista dal 21 al 24 marzo, nove anni dopo la visita del suo predecessore Hu Jintao, che su invito dell’allora premier Silvio Berlusconi partecipò anche alla riunione del G8 a L’Aquila. All’incontro col presidente Sergio Mattarella, il quale è già andato a Pechino nel febbraio 2017, seguirà quello più operativo col premier Giuseppe Conte e con varie aziende per la firma di una serie di accordi che vanno dalla cancellazione della doppia fiscalità fino alla probabile adesione italiana alla Nuova Via della Seta, con la concessione anche di terminali marittimi nei porti di Genova e Trieste, cioè su entrami i lati dello Stivale, e ad accordi con varie aziende. A Pechino fa gola Trieste perché è l’unico porto europeo che gode di extraterritorialità doganale ed è collegato via treno all’Europa centrale e orientale.
Per quanto riguarda Genova è da ricordare che Vasco da Gama il 22 novembre 1497 doppiando il Capo di Buona Speranza (nome dato dal suo connazionale Bartolomeu Dias quando era riuscito a raggiungerlo dieci anni prima senza però proseguire la navigazione verso Oriente) è riuscito in ciò che due secoli prima, nel 1291, era stato tentato con due navi da marinai genovesi: i loro nomi sono Tedisio Doria, Ugolino e Vadino Vivaldi. L’annalista della Repubblica di Genova Jacopo Doria, zio di Tedisio, di loro scrive: “Armarono ottimamente due galee, le diressero nel mese di maggio verso lo Stretto di Setta [oggi Gibilterra] acciò che andassero attraverso il mare oceano alle parti dell’India e di là portassero utili mercanzie”. Delle due navi genovesi e annessi equipaggi non s’è però più saputo nulla: scomparsi in mare. Vasco da Gama durante la risalita della costa orientale africana scoprirà con meraviglia che in Mozambico le navi locali utilizzavano bussole fabbricate a Genova.
Riguardo gli accordi aziendali, stando a indiscrezioni riguarderebbero strade, ferrovie, ponti, aviazione civile, porti, energia e telecomunicazioni, e sono già stati messi nero su bianco dai tecnici del ministero dello Sviluppo Economico, il cui titolare, Luigi Di Maio, è già stato in Cina due volte, l’ultima lo scorso novembre in occasione dell’International Economic and Trade Forum a Shangai. Di Maio a Shangai pur sbagliando il nome del presidente cinese, chiamato erroneamente Ping, ha tenuto un discorso di vari minuti molto impegnativo e molto proiettato a favore degli accordi con la Cina per stimolare le esportazioni del made in Italy. A favorirle molto sarà il polo logistico integrato di Mortara, nel Pavese. Nel giugno del 2017 sono stati firmati infatti accordi ( http://www.terminalmortara.it/ita/sala_stampa/comunicati/articolo5giu2017.pdf ) per collegare Mortara via treno alla città di Chengdu lungo la prima rotta Cina-Italia. Il partner cinese in questa operazione è Changjiu Group (oltre 20 miliardi di fatturato). I treni merci arriveranno in circa 18 giorni e torneranno indietro carichi di prodotti made in Italy. Sono previsti fino a tre viaggi a settimana e il collegamento con Shanghai e Pechino. Il primo treno è partito il 28 novembre 2017.
Con la firma degli accordi con Xi a Roma l’Italia diventerebbe il primo Paese dell’Unione Europea a sostenere la BRI, che ha già raccolto più di cento adesioni di Paesi e grandi organizzazioni internazionali.
Il monito Usa appare alquanto strumentale, visto che il presidente Trump, dopo avere minacciato contro la Cina la guerra dei dazi ora pare che punti a un vasto accordo proprio con Pechino ( https://www.milanofinanza.it/news/trump-accelera-sugli-accordi-con-la-cina-201901311503594427 ), motivo per cui il 27 marzo incontrerà a Mar-a-Lago lo stesso Xi. E suona francamente grottesco e alquanto offensivo l’allarme USA per la possibilità che la Cina acquisti il debito sovrano italiano ( https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2019/03/15/news/cina_gli_stati_uniti_preoccupati_dei_colloqui_fra_xi_e_di_maio_sull_acquisto_del_debito_italiano-221681482/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P4-S1.4-T1 ): il debito USA come è ben noto è stato acquistato a man bassa proprio da Pechino. Non ha quindi tutti i torti la Cina quando il 7 marzo ha sferzato l’Europa con un invito quanto mai esplicito: “Basta sudditanza con gli USA” ( https://www.repubblica.it/esteri/2019/03/07/news/via_della_seta_pechino_sferza_l_europa_basta_sudditanza_con_gli_usa_-220912573/ ). Semmai dobbiamo preoccuparci del punto debole dei grandi piani cinesi: l’enorme debito pubblico interno ed estero di Pechino, che all’inizio dell’anno pari in totale al 317% del PIL ( https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2019-01-13/pechino-e-spirale-fuori-controllo-debito-112455.shtml?uuid=AEweFFEH&refresh_ce=1 )
Uno dei motivi per cui Trump minaccia di intervenire nella recente crisi politica del Venezuela è che tale Paese, ricco di petrolio, ha stretto accordi con la Cina per la sua lavorazione ed esportazione. Il problema è che il mega progetto cinese fa un po’ concorrenza ai due grandi progetti di libero scambio patrocinati dagli Usa: vale a dire al Transpacific partnership (TTP) ( https://it.wikipedia.org/wiki/Partenariato_Trans-Pacifico ), che lega agli Usa gli Stati con i quali gli Stati Uniti hanno avuto a che fare con la seconda guerra mondiale e con quella del Vietnam, e al Transatlantic trade and investment partnership (TTIP) ( https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_transatlantico_sul_commercio_e_gli_investimenti ), progetto di libero scambio tra Europa, Stati Uniti e Canada.
Il monito di Bruxelles suona piuttosto ipocrita visto che negli ultimi 10 anni c’è stata la gara tra i Paesi della UE ad accogliere gli investimenti cinesi: che hanno fatto 227 accordi economici con l’Inghilterra, 225 con la Germania, 89 con la Francia, contro gli 85 con l’Italia. In totale, negli ultimi 10 anni, Pechini ha investito in 30 Paesi europei 225 miliardi di dollari per stipulare 678 accordi societari, 360 dei quali si sono conclusi con il passaggio del controllo azionario in mani cinesi. Accordi, si badi bene, autorizzati e spesso patrocinati dai rispettivi governi, con la cancelliera Angela Merkel, la collega britannica Theresa May e il francese Emmanuel Macron volati a bella posta a Pechino.
Tutto questo attivismo è avvenuto e avviene nonostante la lettera ( http://www.finanzaonline.com/notizie/shopping-cinese-europa-spaventa-italia-germania-francia-scrivono-allue ) che Italia, Germania e Francia il 22 agosto 2017 hanno scritto all’Unione Europea proprio perché allarmate dalla grande campagna acquisti targata Pechino. Ma la cosa strana nostrana – mi si scusi il bisticcio di parole – è che mentre Di Maio e il suo M5S – più il premier Giuseppe Conte, anche se come al solito sottotono – sono molto favorevoli agli accordi con Pechino, a tirare il freno è Matteo Salvini nonostante che il principale sponsor della visita di Xi in Italia è stato proprio un leghista, Michele Geraci, sottosegretario allo Sviluppo Economico, oltre che di suo banchiere e docente in Cina per dieci anni, tanto da parlare fluentemente il cinese. A conti fatti, pare di assistere alla stessa baruffa per la TAV, ma a parti invertite: questa volta a essere contraria invece del M5S è la Lega. E dire che mentre sull’utilità della TAV può anche essere legittimo avere dubbi, sull’utilità della BRI dubbi non ce ne possono essere. Difficile che la Lega vada oltre le enunciazioni di principio e la retorica “patriottica”, visti gli interessi in ballo in piena “Padania” come dimostrano gli accordi e il ruolo di Mortara. I maligni insinuano che mentre Di Maio “guarda a Pechino”, e ne è appoggiato concretamente, Salvini invece “guarda a Mosca”, in particolare al suo presidente Putin, e ne è appoggiato altrettanto concretamente. Come che sia, è evidente che tanto per cambiare c’è un po’ di confusione, al punto che l’economista Renato Brunetta, parlamentare ed ex ministro di Forza Italia, accusa il governo di gestire male questa “grande occasione”, per la quale reclama per l’Italia un ruolo da protagonista.
In soldoni i cinesi anziché mostrare i muscoli e imitare gli USA piazzando basi militari in tutto il mondo imitano semmai i fenici e i portoghesi, che preferivano l’egemonia in terre altrui puntando alla diffusione degli interscambi commerciali tramite una rete di scali portuali. In realtà però c’è da dire che la Cina non imita nessuno perché in passato anziché sviluppare il colonialismo di stampo europeo o la conquista imperiale di territori altrui per dominarli oppure in tempi recenti promuovere la “rivoluzione comunista mondiale” di stampo moscovita, con gli Stati e i territori altrui esterni ai propri confini ha quasi sempre preferito in tutta la sua storia stipulare alleanze tramite accordi commerciali, tributari e magari anche di protezione (unica eccezione l’invasione del Tibet, ma basta un’occhiata alla carta geografica per capire che, per quanto molto deprecabile, s’è trattato di assicurarsi confini in grado di evitare nuove invasioni della stessa Cina). In definitiva la BRI non è che la prosecuzione di tale politica a base di approcci e interscambi commerciali. Per chi non la vede molto di buon occhio la Cina oggi sta riuscendo a fare pacificamente e col denaro quello che i giapponesi provarono a fare con la conquista militare dell’Asia fra gli anni ’30 e i ’40 e poi con la conquista commerciale del dopoguerra.
Sta di fatto che mentre la Cina investe mille miliardi di dollari ( https://www.corriere.it/digital-edition/CORRIEREFC_NAZIONALE_WEB/2018/09/10/15/mille-miliardi-sulla-via-della-seta_U30201076652748OLH.shtml ) nella BRI per collegare il mondo, gli Usa invece ne investono anche di più nella sola produzione di ordigni nucleari ( https://www.ilmessaggero.it/primopiano/esteri/pentagono_nucleare_nuove_testate_deterrente_russia_cina-3525097.html ) più moderni ed efficienti (cioè più distruttivi….), concepiti apposta per tenere sotto pressione proprio la Cina, oltre alla solita Russia costretta così a riprendere la costosissima corsa al riarmo. Trump infatti porta a 1.200 miliardi di dollari i 1.000 stanziati per queste armi da Obama ( http://www.ilgiornale.it/news/mondo/obama-e-i-mille-miliardi-dollari-nuovo-arsenale-nucleare-1214785.html ).
La lunga marcia della Cina verso il predominio commerciale e produttivo in molti settori è iniziata da tempo. Oggi i temi di conflitto per la supremazia tra Usa e Cina sono molti: mercati on-line; hardware; supercomputer; computazione quantistica; navigazione satellitare; intelligenza artificiale; armamenti avanzati; sicurezza nelle telecomunicazioni; potere di imporre gli standard internazionali.
Uno studio accurato della Commissione Europea riguardante il 2016 dimostra che la Cina in quell’anno ha prodotto:
– il 28% delle automobili del mondo (poco meno di un veicolo su tre);
– il 90% di tutti i cellulari;
– l’80% di tutti i computer, e cioè quattro su cinque;
– l’80% di tutti i condizionatori del pianeta;
– il 60% di tutti i televisori assemblati sul nostro pianeta, ovvero più della metà totale;
– il 50% dei frigoriferi fabbricati su scala globale;
– più del 40% delle navi costruite nel mondo intero.
Senza contare l’enorme quantità di merci del settore abbigliamento, sport e casalinghi che la Cina riversa a prezzi popolari nella miriade di negozi e supermercati che ormai costellano ogni città europea.
E’ bene riflettere sul fatto che l’antica Via della Seta e la complementare antica Via delle Spezie non sono state solo millenarie vie commerciali. Hanno infatti alimentato l’Occidente, fin dai tempi dei romani, dei più ambiti beni di consumo, dalla seta alle spezie appunto, ma anche con innovazioni scientifiche e tecnologiche. Basti pensare che Cristoforo Colombo non sarebbe mai potuto arrivare in America senza il timone assiale di coda delle navi e senza la bussola, cose arrivate dalla Cina assieme alla carta, alla cartamoneta, alla polvere da sparo e a molto altro. La stessa America è stata “scoperta” perché i navigatori europei cercavano un modo di arrivare in India, Cina e dintorni per poter continuare gli enormi commerci di spezie e d’altro senza dover passare per i territori ormai in mano agli arabi islamici, che imponevano man mano dazi che moltiplicavano il costo iniziale delle merci anche per più delle dieci volte già lamentate da Plinio il Vecchio per l’enorme esborso annuale di Roma in oro e argento. La matematica occidentale e i computer non potrebbero esistere senza l’apporto dei numeri arabi, in realtà indiani, dell’algebra e dell’invenzione del numero zero, apporto arrivato dall’Oriente tramite quelle antiche vie.
Stando così le cose, cioè la realtà storica, la Nuova Via della Seta può contribuire oltre che a ridare centralità al Mediterraneo come ponte tra Europa, Oriente e Africa anche a correggere il concetto e l’idea di Europa in voga da tempo e il conseguente eurocentrismo (e suprematismo): quello convinto che tutto il sapere moderno – se non tutto il sapere in assoluto – sia nato in Europa. Dimenticando così che l’Europa è nata per volere e interesse della Chiesa, che – anche falsificando come è ben noto il testamento di Costantino – ha voluto separarla dal più vasto insieme di terre dell’impero romano con capitale Costantinopoli. E dimenticando che Costantino aveva voluto trasferire la capitale dell’impero da Roma alla nuova città da lui fondata, e che da lui prende il nome, proprio per avvicinare il centro e il governo dell’impero a quell’Asia che tramite la Via della Seta e quella delle spezie formava di fatto se non un tutt’uno almeno un tessuto comune non solo di commerci con l’impero romano. Spostare la capitale a Costantinopoli significava anche eliminare vari dazi intermedi per le merci, spezie soprattutto, importate in abbondanza dall’Oriente.
Guarda caso, il gas e il petrolio (e alcuni metalli essenziali per i telefonini e computer) senza i quali non possiamo più vivere vengono in gran parte proprio dall’Asia Centrale e dalla Cina: gli oleodotti e i gasdotti corrono più o meno in parallelo o attraversano i territori dell’antica via della seta (in realtà, era un insieme di vie). L’ex Segretario di Stato Zbniev Brzezinsky sosteneva che “Chi controllerà l’Asia Centrale controllerà il mondo”. E infatti gli Usa con la motivazione della guerra al terrorismo islamista cercano mettere anche lì le loro basi militari….
Nel XV secolo la Cina dell’imperatore Yongle aveva iniziato a esplorare il mondo con i 30 anni di navigazioni oceaniche di flotte immense – fino a 30 mila uomini imbarcati e navi fino a 160 metri di lunghezza – al comando dell’ammiraglio Zheng He. Poi però nel 1434 il nuovo imperatore Hung Hsi, figlio di Yongle, decise di eliminare le flotte, proibire la costruzione di nuove navi e distruggere tutti i manuali e le carte nautiche preferendo chiudere la Cina nello splendido isolamento. Circondata da catene montuose, mari e deserti, dai quali ogni tanto emergevano popoli invasori, la Cina si convinse di essere LA civiltà per antonomasia, se non l’unica al mondo, e che questo fosse abitato da barbari. Nell’800, con le invasioni arrivate dall’Occidente, c’è stato lo stupefatto e doloroso risveglio e la constatazione che esistevano civiltà più progredite e aggressive. L’enorme progetto planetario della Nuova Via della Seta è anche la conseguenza di tale amaro risveglio.
Dobbiamo essere grati alla Cina se i ferocissimi mongoli di Gengis Khan, conquistata tra un massacro e l’altro la Russia, arrivati in Ungheria e comparsi brevemente a Vienna e Venezia per un sopralluogo, non sono dilagati anche in Europa, Italia compresa, secoli fa al comando di Batu Khan e Kadan Khan, nipoti di Gengis Khan. Mentre loro erano impegnatissimi ad avanzare anche in Europa lo zio è improvvisamente morto, motivo per cui tornarono indietro per partecipare a Karakorum all’elezione del successore ( https://www.blitzquotidiano.it/opinioni/nicotri-opinioni/salvini-il-capo-col-quid-natura-e-storia-piene-di-esempi-e-puo-finire-male-3005629/ ). Poi per nostra fortuna anziché tornare in Europa per arrivare fino al Grande Mare, cioè fino all’Atlantico, come avevano intenzione di fare, i mongoli preferirono invadere la Cina, all’epoca ben più ricca del Vecchio Continente. Da notare, en passant, che le mogli dei vari feroci khan mongoli erano quasi tutte cristiane, sia pure del ramo nestoriano.
L’ex Celeste Impero sta ponendo fine all’egemonia occidentale sul pianeta, egemonia del resto erosa anche da altri Paesi orientali, come l’India e il Giappone, e da altri in rapido sviluppo come il Brasile, la Turchia e l’Iran. Come fare quindi a dialogare con la Cina in modo da evitare se possibile scontri rovinosi? È una domanda che si pongono anche in Vaticano, specie da quando negli Usa e nelle cancellerie europee ci si è resi conto che è molto flebile la speranza di spaccare la Cina nelle sue quattro parti storiche, esistenti prima della millenaria unificazione, puntando magari su minoranze etniche o religiose, come la minoranza musulmana, quella cattolica o i seguaci della religione Falun Gong ( https://it.wikipedia.org/wiki/Falun_Gong ). La Cina non è né l’Iraq né la Libia né la Siria né l’Ucraina, dove ancora oggi l’Occidente punta al classico “divide et impera”. E non è neppure la Polonia da sottoporre alle spallate antigovernative di Papa Wojtyla. E a tale domanda ha dato una prima risposta l’attuale papa Francesco con la firma il 28 settembre dell’anno scorso di un accordo – per ora provvisorio – in base al quale la nomina dei vescovi della minoranza cattolica cinese, che non riconosce la supremazia del Vaticano, venga vidimata dal papa ( https://www.repubblica.it/vaticano/2018/09/22/news/vaticano_cina_accordo-207083750/ ). La scelta dei vescovi partirà comunque sempre dal basso, cioè dall’Associazione Patriottica dei Cattolici Cinesi (APCC) e dall’Amministrazione Statale degli Affari Religiosi, ma alla fine ci vorrà l’assenso e la firma del Vaticano.
Una delle nostre responsabilità di europei è di ignorare totalmente (anche) la storia dei rapporti tra la Cina e la Chiesa cattolica. Vale quindi la pena farne un veloce ripasso ( https://www.blitzquotidiano.it/opinioni/nicotri-opinioni/agenda-del-nuovo-papa-cina-meno-rigido-1477868/ ). E’ abbastanza noto che il gesuita Matteo Ricci, geografo, astronomo e matematico, riuscì ad arrivare in Cina e a guadagnarsi la stima anche della corte imperiale perché padroneggiava la lingua cinese, ne aveva assorbito la cultura tanto da vivere come un mandarino. Ricci nel primo decennio del 1.600 per compiacere l’imperatore e la sua corte decise di pubblicare una versione modificata e dell’atlante “Mappa completa delle miriadi di Paesi della Terra”. Realizzata con Li Zizhao e pubblicata in migliaia di copie, la Mappa aveva infastidito i cinesi convinti che la Cina – non a caso da loro chiamata Zhongguo, cioè Regno di Mezzo – fosse il centro del mondo e non la periferia dell’ Europa. La nuova versione della Mappa era decisamente più cinocentrica.
Il gesuita Martino Martini, arrivato in Cina nel 1643 sulla scia del dilagare dei portoghesi in Oriente, aiutò l’imperatore Longwu della dinastia Ming, che lo nominò mandarino, a fronteggiare militarmente gli avversari mancesi della dinastia Quing. Esperto di balistica, preparazione della polvere da sparo e della fusione dei cannoni, Martini venne soprannominato Mandarino Polvere di Cannone. Martini riuscì a convincere papa Alessandro VII ad accettare sia pure con riserva che i cinesi convertiti al cristianesimo potessero continuare i loro riti per i morti e per Confucio senza essere scomunicati.
Il gesuita belga Ferdinand Verbiest venne nominato nel 1669 dall’imperatore Kangxi presidente dell’Ufficio delle Matematiche e portò a termine la riforma del calendario cinese iniziata con il gesuita tedesco Adam Schall von Bell. E l’imperatore Kangxi emanò un decreto di libera predicazione del cristianesimo che ricorda molto da vicino l’analogo editto di Milano con il quale Costantino nel 313 aveva sdoganato il cristianesimo dichiarandolo “religio licita”. La penetrazione del cattolicesimo era favorita dalla crisi di rigetto anche da parte delle elite cinesi nei confronti del buddismo, nel cui clero abbondava la corruzione e una eccessiva rilassatezza dei costumi.
I missionari gesuiti erano convinti che per favorire la penetrazione del cristianesimo in Cina si dovesse essere tolleranti e rispettosi di culture antiche e radicate come quella cinese e più in generale asiatiche, ed erano anche convinti che le pratiche invise a Roma fossero solo riti civili, non religiosi. Di parere diametralmente opposto i missionari francescani e domenicani. Fu così che nel 1713 Papa Clemente XI pubblicò la bolla “Ex illa die”, con la quale condannava i riti cinesi ed esigeva a tutti i missionari residenti in Cina il giuramento di rispettare la condanna romana.
La bolla “Ex quo singulari” di Benedetto XIV, pubblicata l’11 luglio 1742, proibì addirittura ogni discussione sui riti cinesi e annessa condanna di Clemente XI, costringendo così gli imperatori Yongzheng e Qianlong a porre un freno alla libertà di predicazione del cristianesimo. E la soppressione della Compagnia di Gesù decisa il 21 luglio 1773 da Papa Clemente XIV non fece altro che convincere i cinesi che i gesuiti avessero mire politiche e fossero quindi davvero pericolosi per l’unità della Cina.
A togliere l’obbligo del giuramento e a consentire ai cattolici cinesi la partecipazione ai riti tradizionali è stato Pio XII nel 1939, anno di inizio della seconda guerra mondiale. Ma con la politica delle scomuniche ai comunisti in blocco e ai vescovi cinesi non disposti a obbedire senza fiatare al Vaticano si è ottenuto solo il rigetto dell’autorità del Papa e la nascita nel 1957 della Chiesa Patriottica Cinese. In pratica, papa Francesco ha per certi versi anticipato intanto sul tema della nomina dei vescovi l’arrivo in Italia e in Europa della Nuova Via della Seta. Contribuendo di fatto anche lui almeno in parte al calo delle tensioni e al recupero del ruolo intercontinentale del Mediterraneo.